CATECHISMO DEGLI ADULTI
|
Quinto comandamento
[885]
Il quinto comandamento “Non uccidere” prescrive con forza il rispetto della vita, che è sacra e viene da Dio: solo Dio è il Signore della vita, dal suo inizio al suo termine. Il comandamento vieta le azioni contrarie alla vita, alla salute e all’integrità, propria e altrui. Proibisce dunque il suicidio, l’omicidio, l’aborto, l’eutanasia, ogni forma di violenza che non sia per legittima difesa. Comanda di promuovere la pace e di evitare la guerra.
| CCC, 2258-2317CdA, 1015-1040 CONFRONTAVAI |
CATECHISMO DEGLI ADULTI
1015 - 1040
|
L’uomo vale per se stesso
[1015] La mentalità materialistica celebra la vita solo nella misura in cui raggiunge il successo, l’efficienza, la ricchezza, il piacere. Non le riconosce un valore in sé e per sé. Perciò finisce per alimentare una cultura di morte, che trova le sue manifestazioni nel disprezzo e nell’emarginazione dei più deboli, nell’aborto, nell’eutanasia, nell’omicidio anche per futili motivi.
| CCC, 356-357 |
|
Valore della vita fisica
[1016]
Un valore assoluto va riconosciuto a quella vita di comunione,
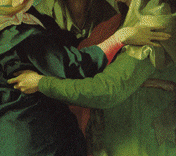 di cui Gesù ha detto: «Sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). Non ha invece un valore assoluto la vita fisica, che all’occorrenza, secondo l’insegnamento del Maestro, bisogna essere pronti anche a sacrificare, per riaverla in pienezza nella vita eterna di cui Gesù ha detto: «Sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). Non ha invece un valore assoluto la vita fisica, che all’occorrenza, secondo l’insegnamento del Maestro, bisogna essere pronti anche a sacrificare, per riaverla in pienezza nella vita eternaD’altra parte la vita fisica, pur non essendo il bene supremo, fa da supporto a tutti gli altri beni e ne consente l’attuazione. Va perciò rispettata dal concepimento alla morte naturale. Va curata e servita in modo che tutti possano avere cibo, vestito, abitazione, lavoro, tempo libero, assistenza sanitaria. Va difesa da ogni forma di violenza e preservata dai pericoli che la minacciano, quali l’alcolismo, la droga, gli incidenti prevedibili.
| CCC, 2288-2291 |
|
Unità di anima e di corpo
[1017]
La coscienza cristiana avverte lucidamente questi doveri, perché ha un’alta considerazione del corpo, elemento costitutivo della persona umana, «destinato alla risurrezione nell’ultimo giorno»
Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 14.
Secondo la concezione biblica, l’uomo è «spirito, anima e corpo» (1Ts 5,23), cioè un soggetto partecipe di energia divina, vivo e pieno di desideri, inserito nel mondo e sottomesso alla caducità. La nostra tradizione culturale preferisce invece parlare di anima e di corpo. Ma quel che conta è affermare l’unità dell’uomo, unico soggetto che vive a vari livelli, posto tra cielo e terra, uditore di Dio e interprete delle cose materiali
Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 14. | CCC, 362-368CdA, 366-367 CONFRONTAVAI |
|
[1018] Il corpo umano è senz’altro un oggetto cosmico tra innumerevoli altri, un punto effimero nell’immensità dell’universo. Ma non si può ridurre a una particella di materia. Già dal punto di vista biologico appare meravigliosamente complesso. Inoltre, fatto ancor più significativo, è integrato nell’esperienza soggettiva della persona.
Io non solo osservo il mio corpo dall’esterno, ma lo vivo consapevolmente dall’interno: nell’agire, nel soffrire, nel toccare, in tutte le mie sensazioni. Io sono il mio corpo. Mediante il corpo ricevo influssi esterni, modifico le cose, comunico con gli altri, esprimo e realizzo me stesso. Una contrazione muscolare diventa nella coscienza un grido di dolore; realtà biologiche come il nascere e il morire, il mangiare e il bere, la sessualità e la malattia si caricano simbolicamente di significati esistenziali. Viceversa, un atteggiamento spirituale diventa gesto concreto: l’amicizia si fa sorriso, sguardo, abbraccio; la fede si fa testimonianza di parole e di opere.
Il corpo è linguaggio; è il dinamico inserirsi del soggetto nel mondo, per incontrare gli altri e rivolgersi a Dio. Partecipa alla dignità della persona ed è chiamato alla gloria eterna. Il rispetto dovuto alla persona si estende dunque anche al suo corpo. «Glorificate Dio nel vostro corpo!» (1Cor 6,20).
|
|
[1019] La persona umana, immagine vivente di Dio, ha valore per se stessa: va rispettata e amata incondizionatamente.
Il corpo è espressione della persona e partecipa del rispetto ad essa dovuto.
|
|
Pazienza cristiana
[1021]
Il cristiano guarda realisticamente alla malattia e alla morte
 come a un male; anzi vede in queste tragiche realtà un’alienazione, carica di tutta la violenza del Maligno e capace di portare alla chiusura in se stessi, alla ribellione e alla disperazione. Non considera però il dolore una pura perdita, non tenta fughe illusorie, né si limita a subirlo fatalisticamente. Messo alle strette dalla sofferenza, continua a credere nella vita e nel suo valore. «Non è affatto un dolore la tempesta dei mali presenti per coloro che ripongono la loro fiducia nei beni futuri. Per questo non ci turbano le avversità, né ci piegano» come a un male; anzi vede in queste tragiche realtà un’alienazione, carica di tutta la violenza del Maligno e capace di portare alla chiusura in se stessi, alla ribellione e alla disperazione. Non considera però il dolore una pura perdita, non tenta fughe illusorie, né si limita a subirlo fatalisticamente. Messo alle strette dalla sofferenza, continua a credere nella vita e nel suo valore. «Non è affatto un dolore la tempesta dei mali presenti per coloro che ripongono la loro fiducia nei beni futuri. Per questo non ci turbano le avversità, né ci piegano» San Cipriano di Cartagine, A Demetriano, 18. La pazienza è una lotta piena di fiducia. Da una parte il cristiano mette in opera tutte le risorse per eliminare la malattia, per liberare se stesso e gli altri. Dall’altra trova nella sofferenza un’occasione privilegiata di crescere in umanità e di realizzarsi a un livello più alto. Se non gli è possibile guarire, cerca di vivere ugualmente; non si limita a sopravvivere. Affronta la situazione con coraggio, dignità e serenità; mantiene la speranza, il gusto dell’amicizia e delle cose belle; confida nella misteriosa fecondità del suo atteggiamento.
Sperimentando nella malattia la propria impotenza, l’uomo di fede riconosce di essere radicalmente bisognoso di salvezza. Si accetta come creatura povera e limitata. Si affida totalmente a Dio. Imita Gesù Cristo e lo sente personalmente vicino. Abbracciando la croce, sa di abbracciare il Crocifisso. Unito a lui, diventa segno efficace della sua presenza e strumento di salvezza per gli altri
Giovanni Paolo II, Salvifici doloris, 19. | CdA, 130-132 CONFRONTAVAI CdA 373-374 CONFRONTAVAI CdA 855-856 CONFRONTAVAI |
|
Alcune attenzioni
[1022]
La sofferenza costituisce una sfida a crescere nella fede e nell’amore; ne è la verifica più sicura: «L’amore vero e puro si dimostra fra mille pene... Chi vuol l’amore, cerchi il patire»
Santa Veronica Giuliani, Diario, 26.12.1694. |
|
Rispetto della vita innocente
[1026]
Non si può attenuare il comandamento di Dio: «Non uccidere» (Es 20,13). Chi non rispetta la vita di tutti, rinnega la
 propria dignità di uomo. Per nessuna ragione può essere giustificata la soppressione diretta di un innocente. La persona umana è un valore assoluto, al quale si deve dare testimonianza a qualsiasi costo. Il soldato che in tempo di guerra si rifiuta di sparare per rappresaglia sui civili inermi, preferendo morire con loro piuttosto che uccidere, non salva nessuna vita, anzi ne perde una in più, la propria; ma intuiamo che compie il suo dovere. propria dignità di uomo. Per nessuna ragione può essere giustificata la soppressione diretta di un innocente. La persona umana è un valore assoluto, al quale si deve dare testimonianza a qualsiasi costo. Il soldato che in tempo di guerra si rifiuta di sparare per rappresaglia sui civili inermi, preferendo morire con loro piuttosto che uccidere, non salva nessuna vita, anzi ne perde una in più, la propria; ma intuiamo che compie il suo dovere.
Tuttavia, in caso di necessità, per tutelare un bene di estrema importanza, può essere tollerata l’uccisione indiretta. È lecito, per salvare una madre, asportare l’utero malato di tumore, anche se ciò comporta la morte del bambino. Tollerare la morte non è la stessa cosa che uccidere.
| CCC, 1737 |
|
Legittima difesa
Il precetto evangelico di porgere l’altra guancia non può essere interpretato come remissività verso qualsiasi attentato alla convivenza umana. Superando l’antica legge del taglione, Gesù vieta la ritorsione violenta: fa riferimento a casi concreti, allora assai frequenti, e chiede di rinunciare a vendicarsi di oltraggi, estorsioni, soprusi, seccature, cercando piuttosto di conquistare con generosa magnanimità il cuore dell’avversario
Secondo l’insegnamento tradizionale della Chiesa, la difesa da un ingiusto aggressore è lecita, a volte perfino doverosa, purché sia proporzionata ai beni minacciati e alla gravità del pericolo; anzi, in caso di rischio imminente per la vita propria o di altre persone innocenti e in assenza di una diversa via di uscita, può arrivare anche all’uccisione dell’ingiusto aggressore.
|
|
Pena di morte
[1028]
Con riferimento a qualche testo biblico
Tantomeno questa pena può essere utilizzata lecitamente come deterrente contro l’espandersi della criminalità. Anzi, il carcere stesso deve essere umanizzato e deve mirare alla rieducazione, e, ove possibile, al reinserimento nella società.
Questa sensibilità per la dignità e il valore della persona umana esprime in maniera più adeguata la visione biblica dell’uomo e della misericordia di Dio verso il peccatore: «Come è vero ch’io vivo - oracolo del Signore Dio - io non godo della morte dell’empio, ma che l’empio desista dalla sua condotta e viva» (Ez 33,11).
|
|
Manipolazioni genetiche
[1030] Il rispetto dovuto alla persona umana consente gli interventi sull’embrione umano solo a scopo terapeutico. Non tollera la manipolazione genetica delle cellule germinali, che aprirebbe la strada a uno sconvolgimento della specie. Esige massima prudenza anche nel modificare il patrimonio genetico delle specie animali e vegetali, per non turbare in modo irreparabile gli ecosistemi assai complessi.
| CCC, 2292-2295 |
|
Trapianti
[1031]
La dignità dell’uomo postula che sia salvaguardata la sua integrità
 fisica. Tuttavia è lecito amputare una parte per la salute di tutto l’organismo o donare un organo a chi ne abbia necessità, purché non si tratti di trapiantare un organo singolo e vitale come il cuore, nel qual caso il prelievo deve avvenire solo dopo accertata la morte del donatore. La donazione di organi è una nuova via che si apre per la solidarietà e la carità; occorre però combattere ogni tentazione di vergognoso commercio. È necessario a questo riguardo educare le coscienze e promuovere un’adeguata legislazione. fisica. Tuttavia è lecito amputare una parte per la salute di tutto l’organismo o donare un organo a chi ne abbia necessità, purché non si tratti di trapiantare un organo singolo e vitale come il cuore, nel qual caso il prelievo deve avvenire solo dopo accertata la morte del donatore. La donazione di organi è una nuova via che si apre per la solidarietà e la carità; occorre però combattere ogni tentazione di vergognoso commercio. È necessario a questo riguardo educare le coscienze e promuovere un’adeguata legislazione.
| CCC, 2296 |
|
Accanimento terapeutico
|
|
Residuo di barbarie
[1037]
Per affermare i suoi diritti, veri o presunti, la comunità politica ricorre talvolta alla violenza collettiva, organizzata, pubblica. È la guerra, «il mezzo più barbaro e più inefficace per risolvere i conflitti»
Giovanni Paolo II, Messaggio per la XV Giornata mondiale della pace (1 gennaio 1982), 12. Cf. Giovanni Paolo II, Centesimus annus, 52.
Agli occhi del cristiano la guerra contraddice il disegno di Dio sulla storia, la sua iniziativa di riconciliazione in Cristo, «nostra pace» (Ef 2,14). Non c’è conquista che possa giustificarla. La pace è preferibile alla vittoria
Cf. Sant’Agostino,La città di Dio, 4, 15. |
|
Difesa armata e suoi limiti
[1038]
Tuttavia, in caso di estrema necessità, qualora ogni altro mezzo
 si sia rivelato impraticabile, non si può negare ai popoli quel diritto alla legittima difesa che non si nega neppure ai singoli uomini si sia rivelato impraticabile, non si può negare ai popoli quel diritto alla legittima difesa che non si nega neppure ai singoli uomini Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 79.
«La potenza bellica non rende legittimo ogni suo uso militare o politico»
Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 79. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 80. | CCC, 2243CCC 2266 |
|
Terrorismo
[1039] Come la guerra totale, merita una netta condanna anche il terrorismo, sebbene abbia una capacità distruttiva molto più limitata. In quanto uccisione diretta e indiscriminata di innocenti, è giustamente ritenuto un metodo criminale di lotta, anche quando l’obiettivo perseguito fosse giusto.
Gravissime sono anche le forme di criminalità organizzata quali mafia, ‘ndrangheta, camorra.
| CCC, 2297-2298 |
|
Edificare la pace
[1040]
La pace non si riduce all’assenza di guerra. È una costruzione politica e prima ancora un fatto spirituale
Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 82.
È dovere dei politici organizzare la pace: eliminare le armi di
 distruzione di massa e tenere a basso livello le altre, destinare le risorse risparmiate con il disarmo allo sviluppo dei popoli, sostituire sempre più la collaborazione alla concorrenza. È dovere di tutti i cittadini educare se stessi alla pace: rispettare il pluralismo politico, sociale, culturale e religioso, favorire il dialogo e la solidarietà in ambito locale e a dimensione planetaria, tenere un sobrio tenore di vita che consenta di condividere con gli altri i beni della terra. «Non è possibile che la pace sussista se non prospera prima la virtù» distruzione di massa e tenere a basso livello le altre, destinare le risorse risparmiate con il disarmo allo sviluppo dei popoli, sostituire sempre più la collaborazione alla concorrenza. È dovere di tutti i cittadini educare se stessi alla pace: rispettare il pluralismo politico, sociale, culturale e religioso, favorire il dialogo e la solidarietà in ambito locale e a dimensione planetaria, tenere un sobrio tenore di vita che consenta di condividere con gli altri i beni della terra. «Non è possibile che la pace sussista se non prospera prima la virtù»San Giovanni Crisostomo, Omelie sulla Lettera agli Efesini, 9, 4. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 79.
Le contese tra gli uomini non cesseranno; la pace perfetta verrà al di là della storia. Il cristiano sa di non avere soluzioni definitive; ma si impegna ugualmente con totale serietà, per attuare un’anticipazione profetica della salvezza: «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,9).
| CdA, 1164-1165 CONFRONTAVAI |




 umano appena formato nel grembo materno, così da poterne giustificare la soppressione diretta con l’aborto. «La vita, una volta concepita, deve essere protetta con la massima cura; l’aborto e l’infanticidio sono delitti abominevoli»
umano appena formato nel grembo materno, così da poterne giustificare la soppressione diretta con l’aborto. «La vita, una volta concepita, deve essere protetta con la massima cura; l’aborto e l’infanticidio sono delitti abominevoli» Inconsistenti appaiono le teorie, secondo cui il feto non sarebbe ancora uomo, perché non è cosciente o non è ancora inserito nella società. Neppure un bambino appena nato è pienamente cosciente; un cerebroleso non lo diventa mai; un addormentato cessa di esserlo temporaneamente. Quanto alla società, non ha certo il potere di stabilire chi è uomo e chi non lo è.
Inconsistenti appaiono le teorie, secondo cui il feto non sarebbe ancora uomo, perché non è cosciente o non è ancora inserito nella società. Neppure un bambino appena nato è pienamente cosciente; un cerebroleso non lo diventa mai; un addormentato cessa di esserlo temporaneamente. Quanto alla società, non ha certo il potere di stabilire chi è uomo e chi non lo è.


